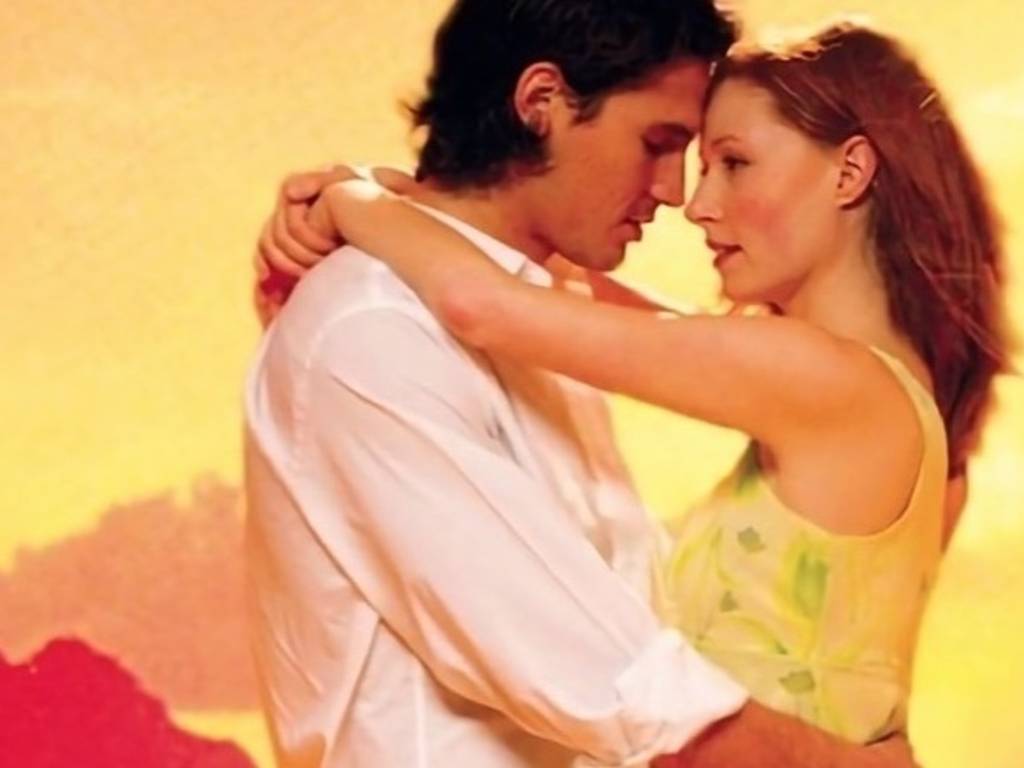“Non nutro più alcuna speranza per il futuro del nostro popolo se deve dipendere dalla gioventù superficiale di oggi, perché questa gioventù è senza dubbio insopportabile, irriguardosa e saputa. Quando ero ancora giovane mi sono state insegnate le buone maniere ed il rispetto per i genitori: la gioventù di oggi, invece, vuole sempre dire la sua ed è sfacciata” è quanto afferma un importante intellettuale le cui opere hanno lasciato un’impronta fondamentale nella cultura mondiale. Mi sembra evidente si riferisca a quella che viene comunemente definita come “crisi dei valori”, in fondo è questa una considerazione condivisa non solo dalla maggioranza dell’intellighenzia occidentale ma anche dalla quasi totalità della cosiddetta “gente comune”. Il dato interessante è che quanto riportato in apertura è stato espresso 2700 anni or sono dal sommo poeta greco Esiodo. Non molto diversa, un paio di secoli dopo, l’opinione di Socrate: “La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, se ne infischia dell’autorità e non ha nessun rispetto per gli anziani. I ragazzi d’oggi sono tiranni. Non si alzano in piedi quando un anziano entra in un ambiente, rispondono male ai loro genitori”. Il suo discepolo prediletto, Platone, rincara la dose: “Oggi il padre teme i figli. I figli si credono uguali al padre e non hanno né rispetto né stima per i genitori. Ciò che essi vogliono è essere liberi. Il professore ha paura degli allievi, gli allievi insultano i professori; i giovani esigono immediatamente il posto degli anziani; gli anziani, per non apparire retrogradi o dispotici, acconsentono a tale cedimento, a corona di tutto, in nome della libertà e dell’uguaglianza, si reclama la libertà dei sessi”. Questa passeggiata nel passato può risalire ancora fino a 3000 anni fa quando a Babilonia si sentenziava che: “Questa gioventù è guasta fino in fondo al cuore. Non sarà mai come quella di una volta. Quella di oggi non sarà capace di conservare la nostra cultura…”
Arriviamo ai giorni nostri, nulla di così diverso nella perenne querelle generazionale, ma davvero possiamo liquidare il problema come espressione dell’inevitabile conflitto che divide la generazione precedente da quella successiva? Intanto è importante, mi sembra, sottolineare come e quanto il piano inclinato della storia stia accelerando così da divaricare esponenzialmente la forbice generazionale. Sarà sufficiente una quasi pleonastica osservazione: la distanza tra i nostri nonni i nostri genitori e noi stessi è sicuramente minore di quella che possiamo esperire tra i nostri genitori, noi ed i nostri figli. Le ragioni? Il progresso tecnologico ha preso a correre tanto freneticamente che ogni innovazione è già obsoleta nel breve volgere di una stagione, tutto diviene immediatamente vecchio e la corsa alla novità è la chiave di volta dell’edificio imprescindibile del mercato. Lasciamo a margine l’aspetto socio economico, che pure riveste un ruolo determinante ma che non potrebbe trovare spazio nella nostra prospettiva, ed andiamo ad indagare quali siano le più rilevanti distanze tra gli attuali “anziani” ed i cosiddetti “giovani”. Intanto gli anziani di oggi sono profondamente diversi da quelli di solo 20 o 30 anni fa, ancora una volta non mi addentro in riflessioni socio politiche ed economiche, infinite sarebbero le sfumature da verificare, ci basti constatare macroscopicamente l’oggettività di diverse rilevazioni statistiche. Ma quella che maggiormente mi preme sottolineare è la duplice radice dell’attuale gap generazionale.
Questa che presento è inevitabilmente una semplificazione ma, mi sembra, utile per una profonda comprensione del problema. Sostengo che l’origine della distanza abissale che rende complesso il rapporto tra le due culture, le due prospettive di osservazione del mondo, le due Weltanschauung, abbia due genitori: genitore uno, come si dice oggi, è un’assenza e genitore due una presenza invasiva. L’assenza è la conseguenza ideologico culturale dell’evento storico politico della caduta del muro di Berlino. Il fatto in sé non ha prodotto immediatamente sconvolgimenti epocali, la riunificazione delle due-germanie è stata metabolizzata dall’apparato dell’Europa unita, che andava connotandosi come nuovo soggetto istituzionale, con tutti gli effetti su mercati e strutture di potere che non interessano la nostra riflessione se non come corollari. Ciò che è assente non è il muro, ovviamente, ma quello che ha significato per decenni: l’antitesi fra due modelli che non erano solo economico politici ma, e forse soprattutto, sovrastrutturali, per dirla con Marx. La cultura dell’economia di mercato, liberista, consumistica e competitiva, aveva come antitesi (alter ego?) quella dell’economia pianificata, statalista, ugualitaristica ed omologante (mi si perdoni l’esasperata semplificazione ma non è luogo per approfondire l’argomento), il mondo del “dopo muro” è quello del “villaggio globale”; del potere assoluto del “pensiero debole”, dell’omologazione produttivo consumistica. Un mondo che sta eliminando le differenze culturali, che abdica a radici profonde, che deve essere sempre più veloce, che consuma per produrre, in cui il pensiero chiede permessi all’economia, in cui l’anelito alle libertà temute da Platone non è più non solo un pericolo, ma nemmeno una possibilità e, ancor meno, un’aspirazione. Coniuge perfetta per tale genitore è l’informatizzazione globale, contemporaneamente causa ed effetto del nuovo mondo, sempre più piccolo, nel quale tutto è vicino e virtuale, ogni cosa è immediatamente imprescindibile e subito dopo superata e vecchia, il pianeta galleggia indifferente nello stato ameboidale e lattiginoso della caducità, nulla ha più peso e vive della sua consunzione. È l’epoca della solidificazione della precarietà, della celebrazione dell’effimero e questa mi sembra una costatazione difficilmente contestabile.
I figli di tali genitori non possono essere altro che i portatori di simili dna, capaci di muoversi a proprio agio nel connettivo della nuova realtà, assumendone caratteri e forme. Sono capaci di gestire rapporti umani a distanza, fragili in quelli più prossimi; raccolgono notizie frenetiche e numerose ma poco criticamente; celebrano la libertà di opinione sposando tesi per simpatia o per circostanza privi come sono di pre-strutture critiche che la cultura precedente forniva, forse manicheisticamente e con supponenza, ai giovani che dovevano, oltretutto, organizzare una ben più esigua quantità di informazioni. Purtroppo queste distanze danno origine, in molti casi, ad una reciproca “difesa preventiva” contrapponendo “ai miei tempi” a “appunto, ai tuoi tempi”. Si, certo, forse è vero che i giovani hanno fretta, vorrebbero liberarsi dal controllo degli anziani, forse ha ragione Platone, desiderano la libertà, che c’è di male? Anzi! Non è ciò che li rende così simili a quello che siamo stati? Una sola nota malinconica: la vera crisi, non nelle eccellenze, mi sembra evidente, è, a mio avviso, quella della competenza. Credo che il nostro tempo sia quello del pressapochismo imperante, del dilettantismo al potere, dell’orgoglio dell’ignoranza, del meglio un calciatore tatuato ignorante e ricco che un colto problematico e disoccupato, ma è obbligo interrogarci: perché i nostri figli galleggiano serenamente ed inconsapevolmente in questa palude che rischia di inghiottirli come sabbie mobili anestetizzanti? Non è forse responsabilità della generazione che li ha preceduti la creazione del territorio melmoso nel quale si sono trovati senza poter scegliere diversamente? Certo, questo non li solleva del tutto dalla responsabilità, infatti qualcuno ha ancora la forza e l’intelligenza per affermare “io no”, ma quanti di noi sarebbero stati in grado di farlo se collocati nel medesimo contesto alla loro età? Mi piace chiudere questa breve digressione con un proverbio dei nativi americani:”Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli”.
Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.
Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero.
Clicca qui per leggere tutti gli articoli