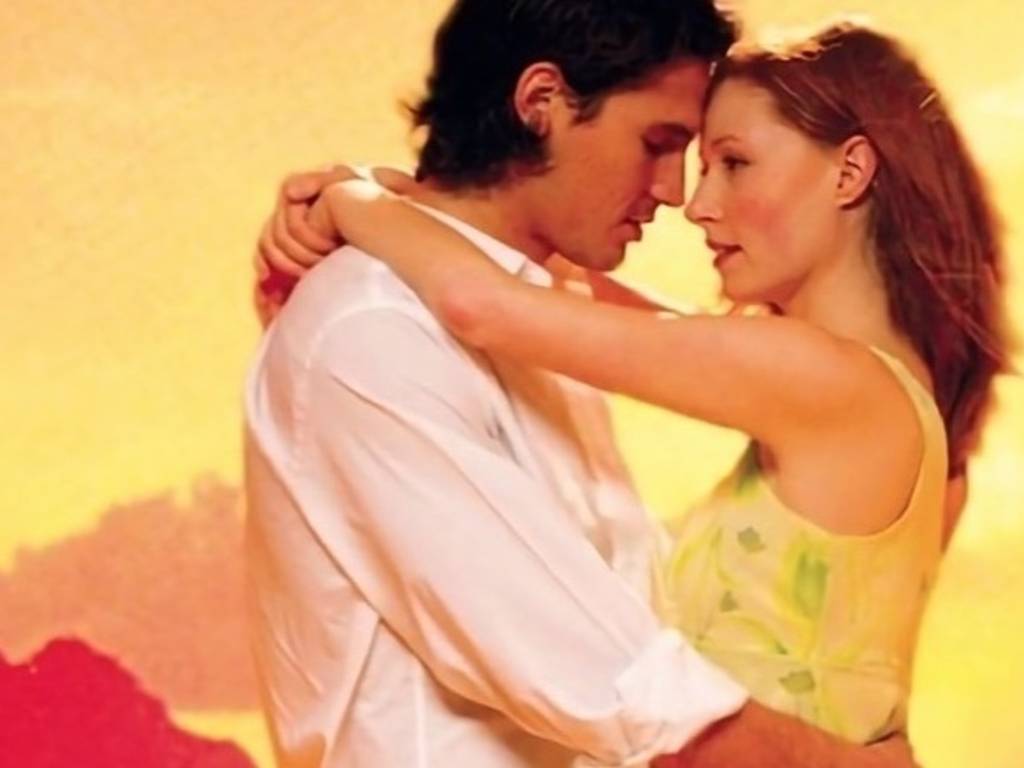Carissimi tutti, vista la stagione, mi pare opportuno parlarvi di castagne, frutto del quale come territorio siamo particolarmente ricchi. Colgo così l’occasione per presentarvi un altro Presidio Slow Food: Castagna essicata nei tecci di Calizzano e Murialdo Per molti secoli il cibo più diffuso nell’Appennino ligure è stato la castagna: economico, conservabile (in farina), era il piatto della tradizione contadina per eccellenza e venne soppiantato, lentamente, solo dall’arrivo della patata. In Liguria la farina di castagne sostituiva quella, più costosa, di frumento, sia nella preparazione del pane, sia in quella della pasta.
In Val Bormida sopravvive un’antica tecnica un tempo diffusa in tutto l’arco appenninico ligure e nelle valli piemontesi: l’essiccatura delle castagne nei “tecci”. I seccatoi, o tecci, sono piccole costruzioni in pietra di un solo locale. All’interno, all’altezza di due o tre metri da terra, un soffitto di graticci in legno, la graia, permette al calore e al fumo di raggiungere le castagne. Ancora oggi, nell’Alta Valle Bormida, si trovano tecci attivi:.dopo la raccolta, le castagne, prevalentemente della varietà “gabbina” (o “gabbiana”), si pongono sui soffitti a graticcio, sopra un fuoco basso e costante alimentato dalla potatura dei castagni o dalla pula.
Al termine delle varie fasi di raccolta, le castagne si girano, portando quelle inferiori allo strato superiore per rendere uniforme l’affumicatura. Dopo questa operazione le castagne sono esposte al fumo ancora per cinque, dieci giorni e poi battute per eliminare la scorza.
Si consumano secche oppure sono ingredienti per biscotti, confetture, creme e gelati. A Natale, con i frutti più grandi e belli, si preparano tradizionalmente le viette: la ricetta prevede di lessare le castagne secche per cinque ore in una pentola con un peso sopra che le mantenga sempre completamente sommerse dall’acqua. Particolarmente dolci, hanno un sapore che ricorda la frutta candita. Il Presidio di Slow Food si propone di valorizzare questa antica tecnica di raccolta e conservazione.
Castagnaccio
Il castagnaccio è un dolce antichissimo che un tempo si cuoceva nei forni di campagna, o sulle piastre bollenti delle case. Nutrientissimo, grazie alle calorie presenti nella farina di castagne, nell’olio e nei pinoli, il castagnaccio fu, per secoli, il dolce dei bambini, soprattutto dei bambini di paese, che cominciavano a mangiarlo in grosse fette calde la sera dei Morti, per smettere soltanto alla vigilia di Pasqua. È un dolce casereccio il cui aroma inconfondibile impregnava le cartelle e i libri di scuola di tutti i piccoli liguri. Diffuso in moltissime aree dell’Appennino italiano, ha in Liguria una leggerezza tutta particolare, data probabilmente dall’olio extravergine e dal finocchietto selvatico.
Nelle zone montane dell’entroterra tigullino e genovese il castagnaccio si chiama Panella e si può preparare sia dolce sia salato. Preparazione e impasto sono uguali: l’unica differenza è la presenza o meno di pinoli, zucchero e uva passa. Il nome, probabilmente, viene dalle “panellette”: focaccine che si cuocevano nei testi, usando farina di castagna o di mais. Le donne che preparavano queste pietanze, erano solite usare un accorgimento particolare per non farle attaccare al testo: mettevano, a modo di “carta forno” delle foglie di castagna sul fondo.
Da un altro modo di preparare le castagne viene un nomignolo usato affettuosamente per i bambini. Quando venivano lessate con la buccia diventavano delle palline, “balette”: e così nelle case genovesi si usa ancora chiamare i bambini più piccoli.
Saluti golosi a tutti.