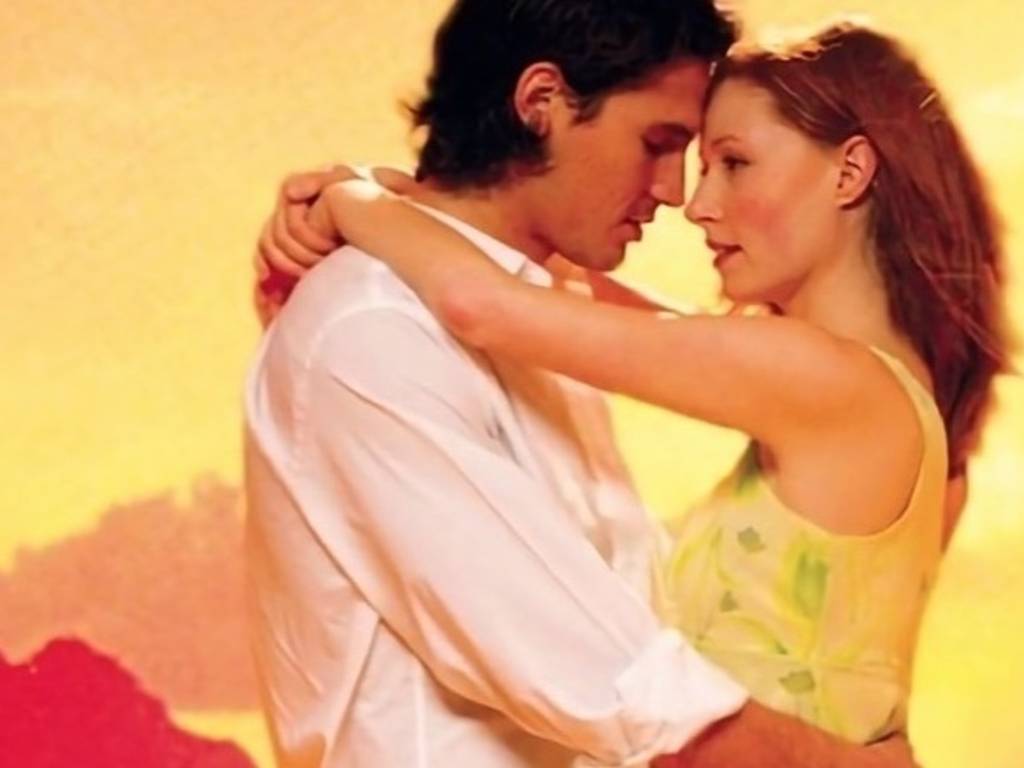Eccoci qua a parlare forse del più “maschio” fra i prodotti tipici liguri. Maschio nell’accezione dei rischi che i maschietti hanno corso nei secoli. È uno dei tanti piatti che la tradizione vuole sia nato dalla fantasia (e dalle necessità) dei marinai liguri. Lo stoccafisso (il merluzzo essiccato al vento alla maniera nordica) è piuttosto diffuso nelle abitudini alimentari dei navigatori mediterranei, che lo hanno utilizzato in modi diversi. Caratteristica di questo piatto è che il prodotto principale non è mai stato e mai potrà essere dei nostri mari, tipica delle cucine marinare che hanno nei secoli carpito tesori gastronomici del mondo.
Il “brandacujun” è facile da preparare ed adatto alla vita di bordo. Si fanno cuocere insieme il pesce e le patate, si uniscono poche cose (un po’ di limone, pepe, aglio, ma alcuni ricettari indicano anche prezzemolo, noce moscata, olive, pinoli e rosso d’uovo) e si aggiunge l’olio extravergine d’oliva. È a questo punto che interviene la “manovra” caratteristica del brandacujun: la pentola viene afferrata e scossa a lungo (da qui il verbo, brandare, che compone la prima parte del nome), fino a ottenere una poltiglia profumata e gustosa. Pare che la seconda parte del nome sia nata nelle giornate di cattivo tempo, quando i marinai dovevano stringere tra le gambe la pentola e il mare mosso pensava al resto.
In realtà, la creazione di questo piatto e il suo nome sembrano molto meno leggendari. Questo tipo di preparazione, della quale Sanremo rivendica la paternità, sembra essere stata importata dalla Provenza, dove è uso sminuzzare finemente lo stoccafisso. In provenzale sminuzzare si dice “brander” e la brandade è un piatto largamente diffuso. Va notato infine che il brandacujun è un piatto “evoluto”: se lo stoccafisso è diffuso in Liguria dal XV secolo, le patate sono arrivate molto più tardi. I marinai (o i cuochi) hanno saputo sposare questi due sapori.
Dopo un po’ di pesce, passiamo ad un dolce: il castagnaccio è un dolce antichissimo che un tempo si cuoceva nei forni di campagna o sulle piastre bollenti delle case. Nutrientissimo, grazie alle calorie presenti nella farina di castagne, nell’olio e nei pinoli, il castagnaccio fu, per secoli, il dolce dei bambini, soprattutto di paese, che cominciavano a mangiarlo in grosse fette calde la sera dei morti, per smettere soltanto alla vigilia di Pasqua. È un dolce casereccio il cui aroma inconfondibile impregnava le cartelle e i libri di scuola di tutti i piccoli liguri. Diffuso in moltissime aree dell’Appennino italiano, ha in Liguria una leggerezza tutta particolare, data probabilmente dall’olio extravergine e dal finocchietto selvatico.
Nelle zone montane dell’entroterra tigullino e genovese il castagnaccio si chiama Panella e si può preparare sia dolce sia salato. Preparazione e impasto sono uguali: l’unica differenza è la presenza o meno di pinoli, zucchero e uva passa. Il nome, probabilmente, viene dalle “panellette”, focaccine che si cuocevano nei testi, usando farina di castagna o di mais. Le donne che preparavano queste pietanze erano solite usare un accorgimento particolare per non farle attaccare al testo mettendo, a modo di “carta forno”, delle foglie di castagna sul fondo.
Da un altro modo di preparare le castagne viene un nomignolo usato affettuosamente per i bambini. Quando venivano lessate con la buccia diventavano delle palline, “balette” o “ballette”: e così nelle case genovesi si usa ancora chiamare i bambini più piccoli.