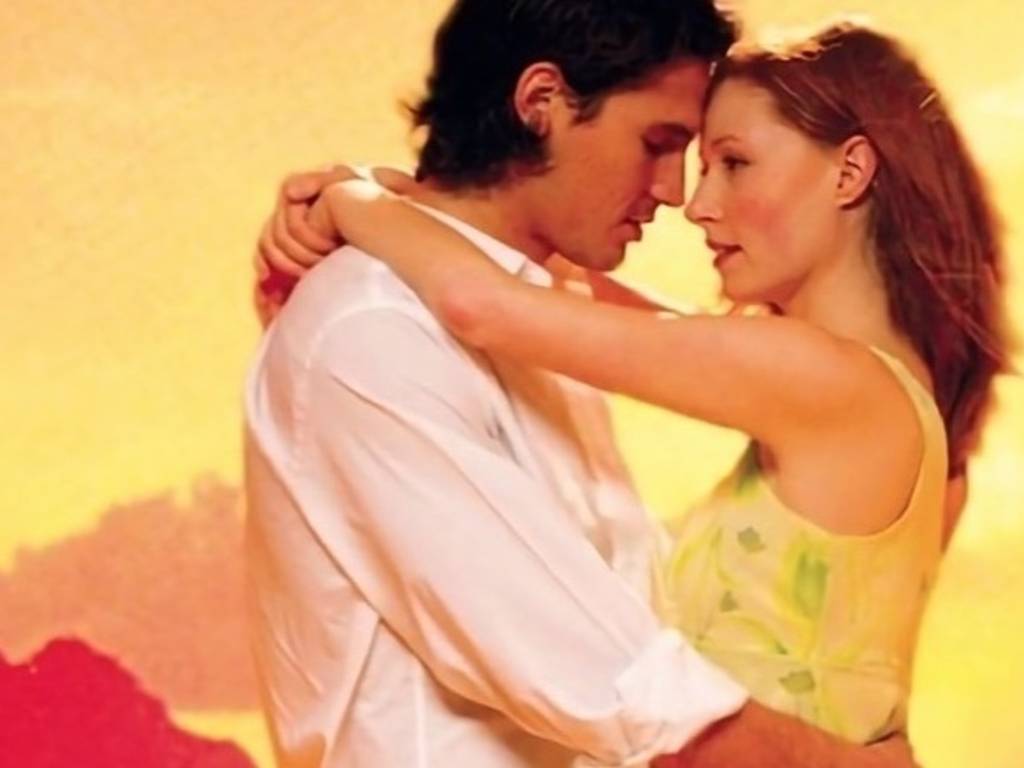[thumb:11326:l]Noli. Si parla comunemente di movimento franoso, ma per un geologo l’espressione non è proprio calzante: quello che è accaduto a Capo Noli, per il secondo anno consecutivo, è per la precisione un “ribaltamento di singoli massi disancorati”. La distinzione terminologica poco conta per i commercianti del levante finalese, per gli automobilisti costretti a bypassare la frana utilizzando l’autostrada o per quelli che scorrendo sulla litoranea rischiavano di essere travolti da un masso, ma l’approccio corretto al fenomeno potrebbe fare la differenza.
Lo spiega Giampietro Filippi, professionista di lungo corso specializzato in geotecnica, che spiega la genesi della parete lungo l’Aurelia, “Gli ammassi rocciosi che formano la zona di Capo Noli e Malpasso, come peraltro quelle di Torre del Mare o della Caprazoppa, hanno ben precise caratteristiche chimico-fisiche e mineralogiche, risalgono a condizioni paleogeografiche instauratesi sul pianeta tra i 250 e i 150 milioni di anni fa ed hanno subito, come un’infinità di altri ammassi nel corso dell’orogenesi alpina in milioni di anni una serie di violenti stress. Gli effetti cioè di quel grandioso fenomeno che, nella migrazione della zolla africana verso quella euroasiatica, ha coinvolto miliardi di sedimenti dell’antico oceano, ha ridotto quest’ultimo all’attuale Mediterraneo, ha prodotto la formazione delle Alpi e di altre catene”.
Gli ammassi quindi, derivati da migliaia di metri di sedimenti marini, sono stati compressi, sollevati, deformati, contorti, rovesciati, costretti a scorrere gli uni sugli altri, spostati di decine di chilometri rispetto alla loro posizione iniziale, per cui, mentre le loro parti più plastiche si sono essenzialmente deformate, quelle rigide si sono intensamente fratturate. “Successivamente, soprattutto nel corso degli ultimi 5-6 milioni di anni – prosegue Filippi – le masse già definitivamente emerse hanno subito ancora altri fenomeni che le hanno ulteriormente indebolite: per primo l’assalto del mare a diversi livelli, con formazione delle falesie, con l’induzione di fenomeni di fessurazione in grande per aver portato le masse a condizioni di verticalità; valgano per tutti due esempi: poco oltre il ciglio della grande falesia che affianca l’Aurelia all’altezza del viadotto del Malpasso, a partire dalla zona dell’osservatorio fino a circa la galleria del Malpasso, è presente una frattura aperta di diversi centimetri, che corre più o meno parallela al ciglio e separa verticalmente la parte esterna della parete dalla zona retrostante; la stessa condizione è quella della zona della Caprazoppa”.
E ci si è messo anche il fenomeno carsico, per cui acque acidulate hanno sciolto la roccia, hanno creato inghiottitoi, grotte, cunicoli, hanno ulteriormente sconnesso, in grande ed in piccolo, la già precaria omogeneità strutturale delle varie masse rocciose. Infine gli stress termici, i fenomeni di dilatazione e contrazione per la variazione dell’insolazione, hanno ulteriormente disarticolato la roccia, soprattutto nei livelli più superficiali. “In queste condizioni è necessario affrontare il problema con molta serietà e con grande consapevolezza dello stato degli ammassi rocciosi – osserva Filippi – gli interventi di superficie, seppur doverosi, non riusciranno mai a risolverlo; è talmente vario, articolato e diffuso tanto in superficie quanto in profondità, che, o si riveste tutta la montagna, partendo dalla zona dell’Hotel Capo Noli e, quanto meno, sino alla Baia dei Saraceni, oppure, se, anche per problemi economici, si procede a settori, cercando le zone che dall’esterno appaiono più sconnesse, ne resterà sempre almeno un’altra che, senza preavviso, potrà rilasciare frammenti rocciosi”.
La soluzione strutturale al problema che oggi si propone è quella di una galleria che sfrutti l’ex tracciato ferroviario. “Personalmente non sono molto d’accordo – è l’opinione di Filippi – Infatti, a parte la oggettiva difficoltà degli innesti sulla Via Aurelia, a levante ed a ponente della zona pericolosa, teniamo presente che la linea Genova-Ventimiglia risale a circa 150 anni fa e che la sezione della galleria dovrebbe essere quanto meno raddoppiata. Di conseguenza si opererebbe in un contesto che attraversa ammassi rocciosi nella condizione che ho appena descritto, interviene su un’opera dove, tra rivestimento e volta e pareti, per 150 anni ci sono state condizioni ottimali per fenomeni di ulteriore alterazione delle condizioni della roccia, dove le venute d’acqua si sono accentuate, dove quindi lo stato complessivo è di precarietà”.
A giudizio di Filippi, pur in altri contesti geologici, ma per gli stessi motivi di fondo, le gallerie ferroviarie, abbandonate o no, hanno indicato una situazione di debolezza. Spiega così: “La galleria che attraversa Capo Vado, quella poco oltre il complesso della ‘Fiorita’ tra Varigotti e Finale, la galleria di Capo Cervo, tutte e tre deformate o franate. E ci si ricordi che la nuova galleria ferroviaria di M. Mao ha richiesto un avanzamento con le tecniche del congelamento, la nuova galleria tra Spotorno e Finale ha completamente drenato l’altopiano delle Manie ed ha intercettato falde carsiche sottraendole al loro naturale percorso”.
Secondo il geologo, la soluzione potrebbe essere una galleria paramassi esterna, perché di più facile realizzazione e di costi inferiori rispetto ad una galleria allargata o del tutto nuova. “Oggi esistono tecniche estremamente valide per realizzarla in termini assolutamente non impattanti, con il rispetto delle peculiarità ambientali e paesaggistiche. Ma, certo, anche in questa ipotesi, vanno effettuate tutte le necessarie verifiche” conclude Giampietro Filippi.