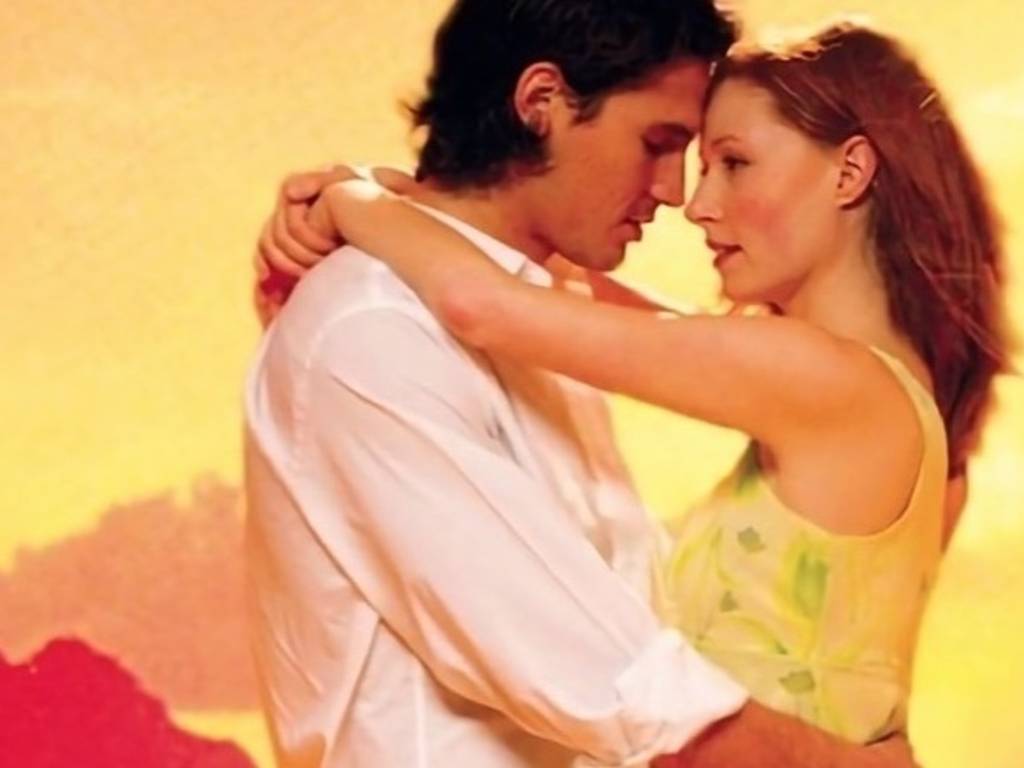Nel comunicarvi che il libro “La Liguria in 100 prodotti” (www.100prodotti.it) sarà in vendita presso lo stand Slow Food del Salone dell’Agroalimentare Ligure a Finalborgo, proseguiamo con alcune schede che potrete ritrovare nel libro. Partiamo allora dai Presidi Slow Food: piccole produzioni di qualità e pratiche tradizionali salvaguardate da Slow Food.
Aglio di vessalico. L’aglio nacque dall’impronta che il diavolo lasciò mentre abbandonava l’Eden. Così almeno racconta la leggenda. Coltivato da sempre, in diverse epoche e luoghi del mondo se ne trovavano testimonianze. Probabilmente le sue origini vanno ricercate nell’Asia centrale e nell’India, i soli paesi in cui la pianta cresce spontaneamente. Nell’antico Egitto era usato dagli schiavi che costruivano le piramidi perché si credeva aumentasse la resistenza agli sforzi. Erodoto scrive di schiavi nutriti con un pezzo di pane, uno spicchio d’aglio e mezza cipolla. In Grecia, durante le Olimpiadi, gli atleti ne mangiavano uno spicchio prima delle gare. Nel Medioevo era chiamato la cipolla del nobile ed era usato in campo magico e medicinale. Coltivato in montagna, in piccoli campi ombrosi, l’aglio di Vessalico, piccolo, aromatico e adatto alla conservazione, viene confezionato in lunghe trecce (reste). Le teste, essiccate, vengono intrecciate a due a due. Ha un gusto forte, lievemente piccante, un profumo delicato. La bontà e le qualità organolettiche dell’aglio di Vessalico sono dovute al clima e alle caratteristiche del terreno dell’area di produzione. In particolare la mitezza del clima di questi luoghi, per la presenza del mare a pochi chilometri di distanza; la natura dei terreni sciolti, derivati da una roccia madre argillosa, ne fa un luogo ideale per la coltivazione di questo “aglio di montagna”. L’aglio di Vessalico, per le sue caratteristiche chimiche e organolettiche uniche, viene protetto come Presidio Slow Food.
Asparago violetto di Albenga. Apprezzati già nell’antico Egitto, gli asparagi erano noti anche ai greci e ai romani e Catone nel 200 a.C. ne descrisse la coltivazione, molto simile a quella odierna. L’asparago ha sempre fatto parte della cucina italiana, e quello di Albenga ha sempre avuto molti estimatori: si racconta che nei palazzi di Roma, già nell’Ottocento, fosse una costante nei menù dei ricevimenti importanti. Inconfondibile, per i turioni grossi e il colore viola intenso che gradatamente sfuma scendendo verso la base, l’asparago violetto d’Albenga è una varietà unica al mondo, portata avanti generazione dopo generazione dai coltivatori della piana. Frutto di una coltivazione assolutamente manuale, il suo periodo di raccolta avviene da metà marzo ai primi di giugno. Privo della caratteristica fibrosità propria degli altre tipologie di asparagi, risulta molto morbido ed è ottimo lessato, magari in pinzimonio con solo olio extravergine di olive taggiasche. In asparagiaie di almeno cinque anni, all’inizio del periodo produttivo sono individuate le piante (10-20 per 1000 metri quadrati) che producono i turioni con le caratteristiche desiderate: calibro grosso, e colore viola intenso. Le piante selezionate, di cui alcune sono femminili e altre maschili, e che fioriscono in un periodo anticipato rispetto a quelle da cui i turioni vengono raccolti, si intercrociano a opera di insetti impollinatori In molti negozi in Italia viene venduto un tipo di asparago viola, a volte non originario nemmeno dell’Italia, ma piuttosto spagnolo. L’asparago violetto di Albenga è tutelato come presidio di Slow Food e potrebbe ottenere la denominazione Igp. Queste sono solo due eccellenze delle 100 che potrete trovare nel libro scritto in collaborazione con Slow Food Liguria. Ricordo che parte del ricavato sosterrà la Fondazione Terra Madre.